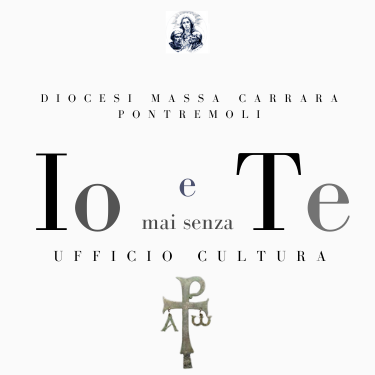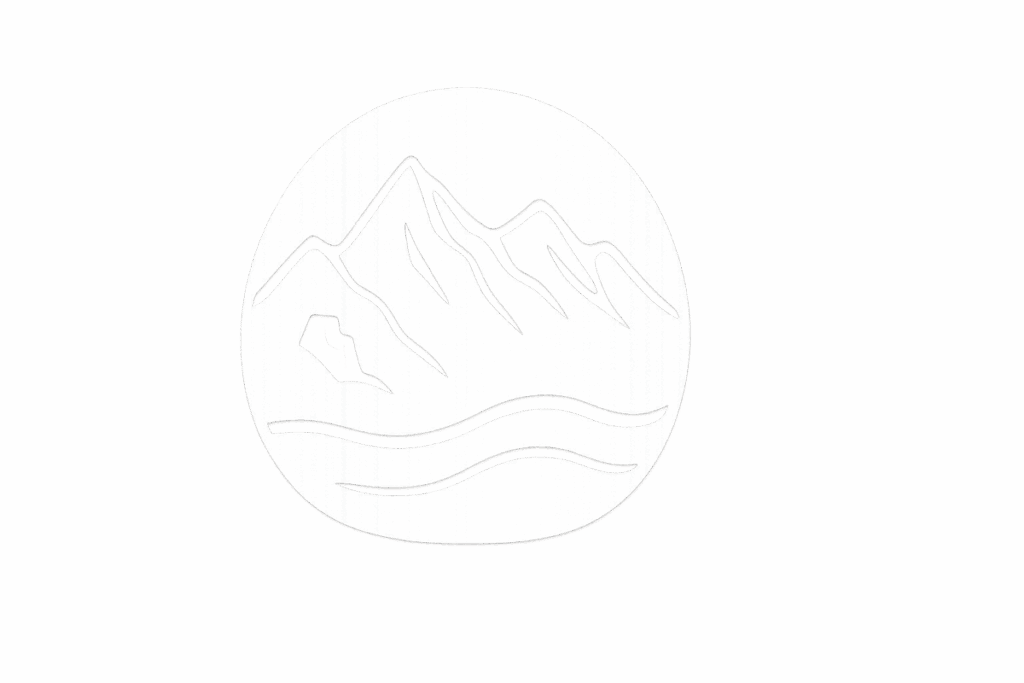«si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali. È necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città»
Papa Francesco, Esortazione Aposolica Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 74
nuovi modi di relazionarsi
si tratta di partire dall’ascolto in vista di abitare lo spazio apertosi per condividere il senso sapienziale che abita lo spazio cristiano; un ascolto in cui, allo svelarsi dell’altro, comprendiamo noi stessi nell’altro; in cui, insieme, veniamo ad essere compresi non senza l’altro ma solo con l’altro. Non c’è spazio per un sé senza l’altro, ogni altro e ogni altra cosa.
l’emergere dei valori fondamentali
Di valori siamo già ben forniti, si tratta di suscitarli. Spesso li anteponiamo o li presentiamo come qualcosa di già dato, mentre i valori emergono alla nostra coscienza quando, fatto silenzio in noi, lasciamo che nell’ascolto sia l’altro a porci sulla strada su cui Gesù passava.
Quello è il luogo in cui i valori si trovano: sulla strada, nell’incontro. I valori non abitano nell’iperuranio – questo è il mondo platonico che non sa nulla della prossimità di Dio, della sua incarnazione – né sono un possesso sicuro, sigillati in scrigni, ma sorgono dal basso.
Il Signore dona dall’alto ciò che fa sorgere dal basso, genera figli e ci fa scoprire fratelli.
Ciò che si possiede lo si ritrova solo se accolto, posto in atto con un altro: ‘io e te’.
partecipare alla scrittura dei nuovi racconti e paradigmi
Questa prossimità diventa il luogo in cui ciò che si possiede viene ad essere nuovamente riformulato, accanto all’altro con cui si è scoperta la propria identità: con l’altrui e per l’altrui identità.
Non si tratta di usare formule consumate o celebrate, ma di riappropriarsene dicendole con l’altro e per l’altro. Non c’è più nessuno che ha voglia di ascoltar parlare di sé da un altro.
Oggi si ha voglia di essere narratori della propria identità, co-narratori, story-tellers della propria identità e di entrare nella narrazione di qualcun altro, di essere da un altro narrato.
Occorre quindi essere capaci di abitare questi spazi narrativi/generativi di identità. Non si tratta dei nuovi mezzi di comunicazione, no: si tratta invece dei nuovi spazi di identità dove sorgono le narrazioni in cui sentirsi parte, in cui ricevere il proprio posto e ruolo perché si sa che chi noi siamo è frutto di un intreccio di libertà e grazia, di graziosa offerta e rinnovata possibilità di dirsi al di là del già detto.
imparare dallo stile di Gesù
In fin dei conti questo è ciò che ha fatto Gesù. Entrò nella quotidianità dell’umanità, abitandola non da fuori.
Non basterà mai meravigliarsi di ciò che avvenne: quell’uomo, Gesù, è Dio! Non un Dio che si è fatto uomo ma che uomo non era; no: quell’uomo Gesù è l’unico modo per dire ‘Dio’.
Non uno spazio di pre-esistenza del divino cui segue una esistenza terrena che, terminata, riconduce alla condizione di pre-umanità; no: Lui solo, proprio Gesù, sa dire chi è Dio perché lo è, nella sua identità veramente umana e solo così veramente divino filiale.
Ciò che dovettero fare i discepoli fu di riconoscere che Colui che è il Risorto fosse lo stesso che avevano imparato a conoscere nella relazione vissuta con lui, nelle narrazioni in cui erano stati inseriti da lui mentre parlava loro del Regno e del suo avvento, mentre parlava loro della sua relazione col Padre, che da suo proprio diventava ora loro e quindi ‘nostro’.
Questo essere inseriti in quella narrazione ha fatto sì che prendessero vita le loro narrazioni di quell’incontro, proprio come nell’incontro con quel mondo avevano preso vita le narrazioni di Gesù.
È stato per 30 anni in silenzio, attento ad ascoltare il cuore dell’uomo, le attese di un futuro messia, di una salvezza personale e di gruppo in mezzo ad popolo sottomesso e conquistato, a sentire il vibrare del desiderio della libertà che scendeva però a compromessi e barattava la libertà con piccole regalie concesse dal potere di turno, religioso o meno.
Per 30 anni è cresciuto sentendo una narrazione e in quella ha udito la voce del Padre, cosicché quelle separazioni tra sacro/impuro, tra elezione/riprovazione, tra mondo/spirito non erano più possibili perché non ospitavano più l’avvicinarsi del Padre nel Figlio inviato per il mondo e non solo per la casa di Israele; ha sentito parlare di una salvezza che si aggiungeva alla propria vita con l’esercizio delle buone opere, nell’obbedienza ad una parola creduta e venuta dall’alto, un farsi giusti riuscendo a non occuparsi dell’altro ma solo di sé e ha dovuto mostrare che il Padre lo aveva inviato nel mondo, nato da sangue e carne, facendo proprio il destino di quel mondo perché fosse colto come il luogo della vicinanza incondizionata di Dio, nonostante anche il peccato.
Dalla sua narrazione – spesso lasciata all’uso delle parabole, all’uso della narrazione nelle narrazioni popolari – e dalla sua presenza nella storia delle persone incontrate nella loro quotidianità è nata la sua narrazione.
Si tratta di dare un con-testo a tutto ciò che la fede cerca quando decide di incontrare lo sguardo di Dio.
Questo è l’esercizio che ancora oggi occorre svolgere: stare nella narrazione della vita delle persone e starci narrando in esse la prospettiva che viene dall’essere narrati stando assieme agli altri. Essere lievito (cf. Mt 13,33) non significa fare dell’intero impasto solo del lievito, ma lasciare che la farina e l’acqua crescano assieme, si fecondino, mentre il lievito scompare, servo inutile (cf. Lc 17,10).
Non si tratta di abitare spazi dove il nostro ‘io’ sta di fronte a diversi ‘tu’, ergendoglisi di fronte, quasi dialetticamente, in una incomparabile differenza e distanza, col rischio che l’altro soccomba, si pieghi, scompaia.
Occorre imparare a dire ‘io e te’, imparare ad abitare spazi terzi: non senza l’altro ma assieme agli altri, alle velocità che solo due sanno raggiungere, perché non si raggiungono da soli o portando gli altri al proprio seguito.